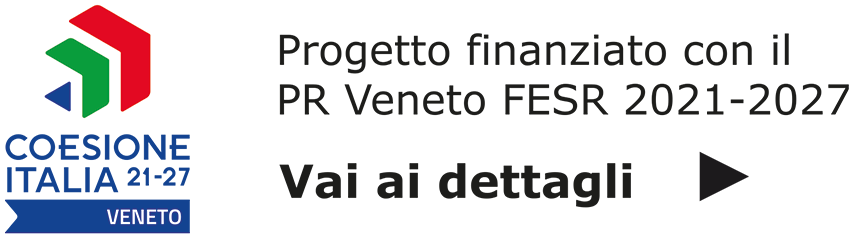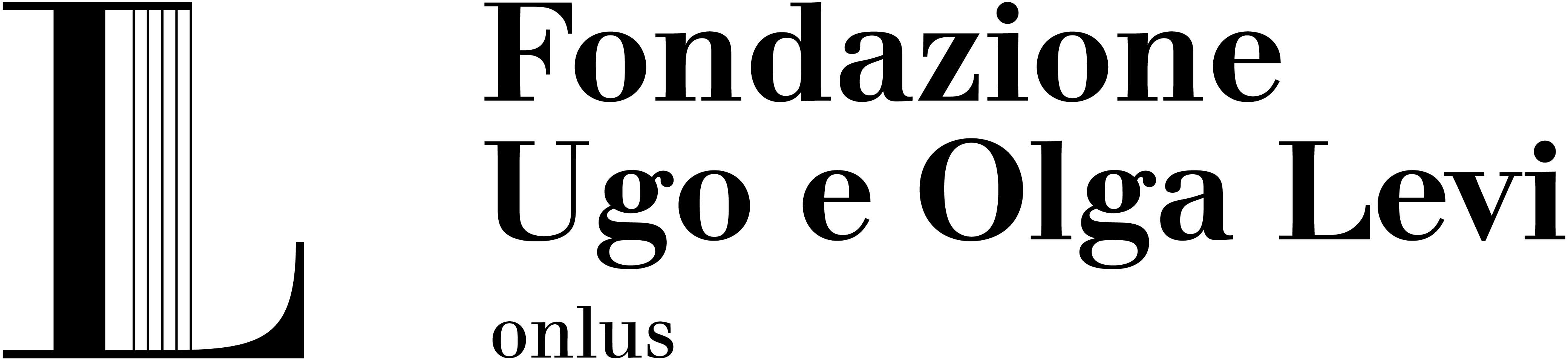Maggio Musicale Fiorentino. La Musica nel Film, 1935
|
IDENTIFICAZIONE |
Tipologia
materiale a stampa Tipologia specifica
spoglio Segnatura precedente
FM-2016-235
|
|
INFO PUBBLICAZIONE |
Contenuto in (periodico)
Numero/Annata
1935, II, nn. 11-12 Pagina
246-247
Luogo di pubblicazione
Roma
Editore
[s. n.]
|
|
RESPONSABILITÀ |
autore
|
|
CONTENUTO |
Abstract
Come indicato all'inizio dell'articolo, si tratta di «una breve cronaca del Convegno di Firenze su la musica nel film, svoltosi nei giorni 28, 29 e 30 del maggio scorso» (1935), svoltosi nell'ambito delle manifestazioni del Secondo Maggio musicale fiorentino (1935). Senza alcuna descrizione del contesto e dell'orientamento generale del convegno, il giornalista sintetizza in poche righe ognuna delle relazioni presentate al convegno. Paolo Milano ha letto una relazione «sull'estetica nell'impiego del sonoro». Roland-Manuel ha letto una relazione «sui rapporti fra ritmo sonoro e ritmo cinematografico». Secondo Sebastiano Arturo Luciani la musica è «il tessuto connettivo del film», tuttavia «il musicista dovrebbe essere un subordinato del regista: come il librettista del melodramma è sottoposto al musicista». Secondo Rudolf Arnheim «l'espressione musicale ha un valore integrativo rispetto alla parte visiva del film», non come sostengono i «russi» che essa «deve [
] sottolineare o addirittura svolgere i sentimenti dei personaggi». Secondo Giacomo Debenedetti, il migliore esempio di sonoro è stato realizzato con i cartoni animati di Topolino realizzati da Disney. In quel caso, infatti, il suono ha una natura soltanto evocativa ed è del tutto estraneo al «dominio del reale». Daniele Amfitheatrof ha descritto il piano di lavorazione per un musicista che lavora in ambito cinematografico. Inoltre, «ha esposto rilievi interessantissimi circa l'impiego delle orchestre nell'acustica delle sale cinematografiche». Arrigo Usigli ha portato una relazione «sulle principali caratteristiche degli strumenti musicali in rapporto alla registrazione del suono». Gavino Gabriel, invece, ha denunciato la scarsa professionalità con cui viene realizzato il montaggio sonoro. Emile Vuillermoz ha denunciato il «regime umiliante di totale sottomissione imposto ai musicisti negli "studi"». Luigi Colacicchi si è scagliato contro il parlato che «deve quindi essere ridotto e a mano a mano escluso, affinché lasci la via libera a una sorte di recitativo».Boris De Schlzer ha «fatto gravi riserve sul cinema, inteso come opera d'arte». Pertanto, «la musica del film sarà sempre un prodotto artistico di secondo ordine». Umberto Margadonna si è soffermato sull'importanza di «produrre film che risultino esportabili». Per questo, suggerisce la creazione di «un melodramma cinematografico che possa sostituire nell'esportazione il glorioso melodramma nostro». Herbert Fleischer «ha detto che il timbro dell'orchestra adoperato per le sonorizzazioni deve essere adeguato a quello particolare meccanico della colonna stessa». Dopo aver esaltato il cinema, «creazione collettiva», come «l'arte più moderna e la più ricca di possibilità», Umberto Barbaro ha ridotto «l'importanza della musica nel film perché il film ha un carattere « esclusivamente narrativo e moralistico». Dopo aver segnalato che, tra una relazione e l'altra, sono intervenuti nel dibattito, oltre ai relatori, anche Darius Milhaud e Maurice Jaubert, ha segnalato che Alberto Passigli «ha pronunciato il discorso di chiusura salutando i convenuti e annunciando l'istituzione di un premio per la musica del film, premio che sarà assegnato durante il terzo Maggio musicale».
|
|
CHIAVI DI ACCESSO |
Persone
Milano, Paolo (persona citata)
Luciani, Sebastiano Arturo (persona citata)
Debenedetti, Giacomo (persona citata)
Usigli, Arrigo (persona citata)
Vuillermoz, Émile (persona citata)
Barbaro, Umberto (persona citata)
Disney, Walt (persona citata)
La Fontaine, Jean (persona citata)
Passigli, Alberto (persona citata)
Roland-Manuel (persona citata)
Arnheim, Rudolf (persona citata)
Amfitheatrof, Daniele (persona citata)
Colacicchi, Luigi (persona citata)
Schloezer, Boris de (persona citata)
Milhaud, Darius (persona citata)
Jaubert, Maurice (persona citata)
Margadonna, Umberto (persona citata)
Fleischer, Herbert (persona citata)
|
Hai delle richieste o dei suggerimenti da segnalarci riguardo questa scheda?
Compila per favore il modulo sottostante. Ti ricontatteremo appena possibile.