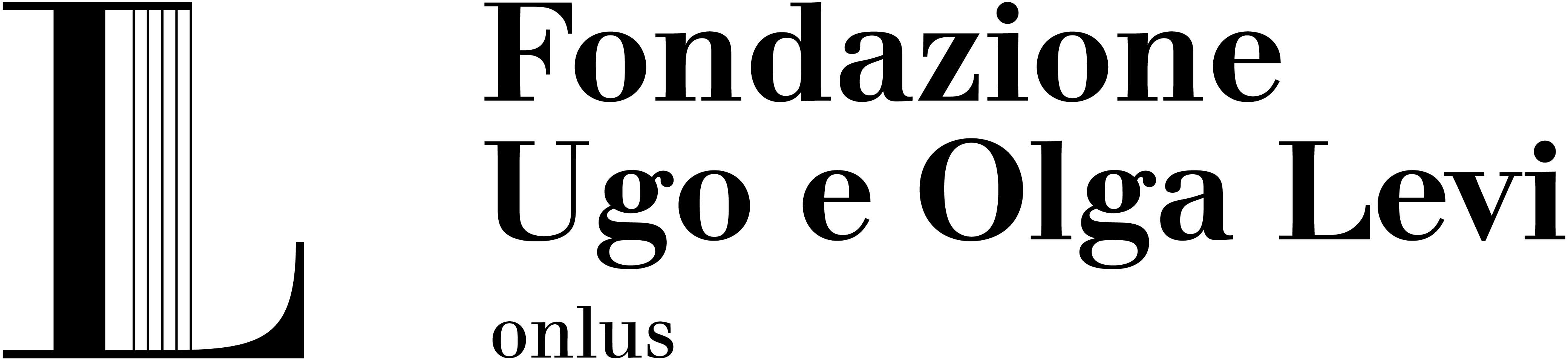Cinematografo e musica, s.d.
|
IDENTIFICAZIONE |
Tipologia
materiale a stampa Tipologia specifica
spoglio Segnatura precedente
FM-2016-061
|
|
INFO PUBBLICAZIONE |
Contenuto in (periodico)
Luogo di pubblicazione
Bologna
Editore
Arte della stampa
|
|
RESPONSABILITÀ |
autore
|
|
CONTENUTO |
Abstract
Lo scritto s'incentra su uno dei nodi più dibattuti nella teoria cinematografica e nella pubblicistica degli anni Venti: il sottile equilibrio fra vista e udito, fra visione e ascolto, nello spettacolo cinematografico. La presenza di un accompagnamento musicale a sostegno della proiezione è certo ormai un fattore essenziale e irrinunciabile: il silenzio delle figure avrebbe di contro un effetto «penoso, opprimente, irritante». Importanti progressi sono stati inoltre compiuti da quando si è compreso che, «per raffinare e completare il godimento estetico prodotto dalla pellicola», era necessario predisporre un «accompagnamento preordinato» e dismettere la prassi degli accompagnamenti casuali ed estemporanei. Vi è tuttavia un limite sensibile da non oltrepassare: «La musica deve sempre rimanere un accessorio: la parte principale ha da restare al cinematografo». Alla musica - sostiene l'autore, rifacendosi agli scritti sul cinema di Simonetti e Galassi, in polemica con le tesi di Alberto Gasca (ndt) - è richiesto di coadiuvare la cinematografia, senza sopraffarla; l'orecchio deve integrare e completare la sensazione visiva, senza disturbarla. Basterà che il commento musicale si adatti genericamente al carattere delle varie scene, «senza bisogno d'innalzarsi ad altezza vertiginose e di cimentarsi con difficoltà tecniche eccessive». L'essenza dell'arte muta si dirige infatti soprattutto all'organo della vista, e soltanto in linea secondaria all'organo dell'udito. Questo dato sostanziale è all'origine del fallimento dei pochi, isolati tentativi di fondare un «dramma musicale cinematografico», come il Christus di don Giocondo Fino, Rapsodia satanica di Pietro Mascagni, Frate Sole di Luigi Mancinelli. |
|
CHIAVI DI ACCESSO |
Persone
Musiche
Film
|